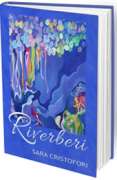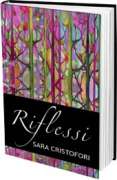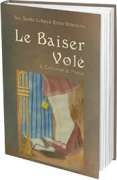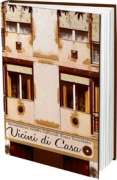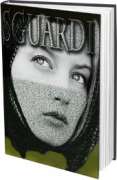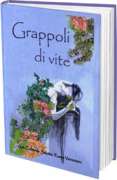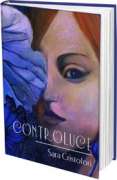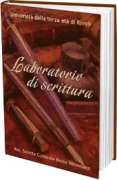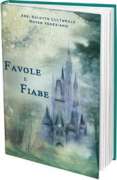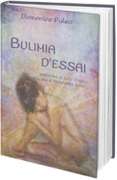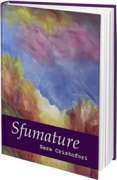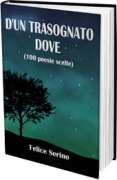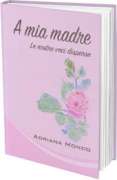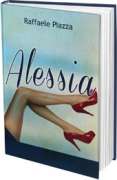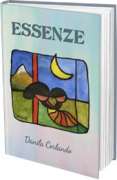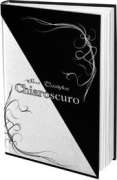Scritto da © Hjeronimus - Ven, 23/12/2011 - 13:46

Ora, io sono giunto a considerare che la più alta istanza che noi siamo in grado di sollevare al mondo sia la nostra stessa grandezza d’animo. Sembra semplice, quasi banale, ma non lo è. Il principio di valore viene massimamente adottato dal genere umano come qualcosa di pertinente al suo proprio bisogno, di modo che la stessa idea di prosperità, di ricchezza, è collegata ad un archetipo di eccesso di soddisfazione: la ricchezza equivale alla disponibilità di un troppo, di una dismisura nella disponibilità dei beni. È ricco chi può impunemente consumare senza preoccupazione. E se quelli si chiamano beni, si chiama ricco chi gode liberamente di questi valori.
Il “troppo” diviene così un valore tale che nel Rinascimento, per esempio, l’archetipo della bellezza ideale è “troppo” anch’esso: l’uomo “manierista” è troppo muscoloso; la donna troppo formosa e ridondante (oggi la si direbbe “grassa”). Tale è il modo di collegare quel tema a un modello “pulsionale” del principio di valore. Un modello venale che, nel momento in cui connette la propria idea di felicità con la soddisfazione soltanto biologica dei propri appetiti, nega proprio quella vocazione astratta insita e vincolata nel principio di valore.
Storicamente, con l’avvento della cosiddetta “coscienza etica” il principio di valore viene ad innestarsi su un sistema di regole, il rispetto delle quali implica la determinazione della giustezza e quindi della validità morale della coscienza che discerne tra bene e male. Il valore si trasferisce già su un piano immateriale, di per sé, ma tale determinazione è comunque asservita ai desideri e alle esigenze di qualcuno che lo pilota, ordinariamente un sacerdote-monarca, un “papa-re” che ben di rado è ligio al decalogo che impone agli altri. Questo “sistema delle regole”, pur mutando e adeguandosi ogni volta alle nuove occorrenze, resta più o meno in auge fin qui, fino a noi. E noi stessi lo ribadiamo: ci vogliono delle regole per la convivenza civile, cui tutti siano in qualche modo obbligati e il rispetto delle quali concretizzi una sorta di sfera valoriale cui l’intera comunità possa far affidamento e riferimento. E va bene. Ma questo è il Diritto, non il Valore. Il diritto, è ovvio, è un valore in sé, ma si tratta di una costruzione nostra, in natura non c’è il diritto e ognuno si prende quando e come può tutto quello che può. Ossia, esso non è un valore fondativo, assoluto, che emerge da necessità intrinseche dell’essere. È valore per la società, non valore in sé. Detto altrimenti: il diritto non scaturisce da una necessità ontologica dell’essere, bensì da una necessità morale. Di conseguenza deriva dal Logos, non è esso stesso Logos.
L’in sé del valore viene genericamente identificato con una sostanza metafisica che si dispiegherebbe parallelamente all’esserci umano, al Dasein, come lo chiamano i Tedeschi. Ma questa accezione del valore non è condivisibile, né del resto gode di una sufficiente determinazione ermeneutica. Il valore della inferenza di tale sostanza sull’esserci è troppo poco semantico, per dire così, dispone di un linguaggio troppo ristretto e unilaterale per “stringere” davvero sull’essenza del valore di ciò che io sono, qui e ora. Il valore deve essere laico per essere attivo, altrimenti se ne può derogare fin troppo agevolmente, basta guardare per esempio alle avventure vaticane dei figli, e persino figlie, del pontefice, papi a loro turno.
Il valore è ciò che frena dall’infrangerlo, e non per obbligo di legge. Solo perciò è anche ciò che irrora di senso la nostra vicenda terrena. Il senso della nostra vita è quindi transustanziale con un principio primo da cui gli altri non possono che derivare, e questo principio è il valore che esso implicita nella vita stessa. Quindi la domanda è: cosa non deroga mai da se stesso? Cosa ha la forza intrinseca, cogente di travalicare persino il mio interesse in virtù di qualcosa di maggiore del mio interesse? Cosa è maggiore dell’interesse, del profitto particolare, egoistico e comunque concreto del mio tornaconto? Esiste una cosa così?
La mia risposta è: questa cosa esiste ed è la grandezza, ossia la mia grandezza, il mio sentire grande. Non nel senso di una mia qualità particolare, ma in quello di una possibilità di quel sentire che è comunque essente in noi al grado più alto e ultimo di tale essere. Un requisito di cui la natura ha voluto in ogni caso dotare ognuno di noi e che soltanto il nostro capriccio dispone al meglio o al peggio. Quindi, chi declina la propria grandezza in misura del tornaconto che tale palinodia gli promette, frena sul senso della propria vita a beneficio dell’agiatezza che questa frenata gli restituisce. Senza considerare che, se il senso della vita è frenato, quell’agiatezza non serve a nulla, perché non serve al suo cardine più radicale, appunto il senso.
(Si potrebbe qui innestare un discorso sull’autostima: questa è un valore e per non infrangerlo, ossia per il rispetto di me stesso, evito l’atto corruttivo causa dell’infrazione. Questo non basta e non funziona. Se “ogni uomo ha un prezzo”, come vien detto, tale è proprio il prezzo dell’autostima, cui placidamente si rinuncia in cambio di un bel gruzzolo.)
È questa la risposta alla domanda etica (la Teodicea): se il valore di ciò che è, cioè il mio valore, è sussunto a qualcosa che è in me, e non altro, estraneo da me, il senso della mia vita è interconnesso alla mia facoltà di far valere come grandezza, ossia in modo assoluto, questa mia scoperta del valore. Se rimpicciolisco questo mio obiettivo piegandolo a interessi particolari e circoscritti, infango il mio orizzonte più vasto a favore di un microcosmo più gretto e mediocre, generando discredito su di me e collera in altrui. (esempio: il politico corrotto). E perché non farlo, se se ne trae un vantaggio venale? La questione cade proprio qui: solo il valore come grandezza morale si oppone a questa domanda. Se, diciamo, un sia pur piccolo bottino sembra più grande della mia presunta grandezza, allora è il senso della mia vita che è discreditato: è perché io non so pensarla una tale grandezza che mi accontento di una piccola parcella in contro-moneta del mio credere in me. È l’essere-meschino il controvalore del valore dell’essere. È l’immeschinimento della grandezza necessaria dello spirito a rendere vano e anacronistico il principio stesso del valore.

Vorrei, ancora una volta, scandagliare il tema del valore. Perché il valore, pur essendo astratto in sé, è il concetto che conferisce senso alle cose umane, dal che si evince pure come tutto ciò che chiunque al mondo può prefiggersi, al di là della pura fame, è di sfamare la sua brama di astrazione, cioè a dire, se pur sia qualcosa, il suo spirito (e qualcosa deve pur essere, se appunto il suo sostentamento è la più alta guglia dell’essere).
Ora, io sono giunto a considerare che la più alta istanza che noi siamo in grado di sollevare al mondo sia la nostra stessa grandezza d’animo. Sembra semplice, quasi banale, ma non lo è. Il principio di valore viene massimamente adottato dal genere umano come qualcosa di pertinente al suo proprio bisogno, di modo che la stessa idea di prosperità, di ricchezza, è collegata ad un archetipo di eccesso di soddisfazione: la ricchezza equivale alla disponibilità di un troppo, di una dismisura nella disponibilità dei beni. È ricco chi può impunemente consumare senza preoccupazione. E se quelli si chiamano beni, si chiama ricco chi gode liberamente di questi valori.
Il “troppo” diviene così un valore tale che nel Rinascimento, per esempio, l’archetipo della bellezza ideale è “troppo” anch’esso: l’uomo “manierista” è troppo muscoloso; la donna troppo formosa e ridondante (oggi la si direbbe “grassa”). Tale è il modo di collegare quel tema a un modello “pulsionale” del principio di valore. Un modello venale che, nel momento in cui connette la propria idea di felicità con la soddisfazione soltanto biologica dei propri appetiti, nega proprio quella vocazione astratta insita e vincolata nel principio di valore.
Storicamente, con l’avvento della cosiddetta “coscienza etica” il principio di valore viene ad innestarsi su un sistema di regole, il rispetto delle quali implica la determinazione della giustezza e quindi della validità morale della coscienza che discerne tra bene e male. Il valore si trasferisce già su un piano immateriale, di per sé, ma tale determinazione è comunque asservita ai desideri e alle esigenze di qualcuno che lo pilota, ordinariamente un sacerdote-monarca, un “papa-re” che ben di rado è ligio al decalogo che impone agli altri. Questo “sistema delle regole”, pur mutando e adeguandosi ogni volta alle nuove occorrenze, resta più o meno in auge fin qui, fino a noi. E noi stessi lo ribadiamo: ci vogliono delle regole per la convivenza civile, cui tutti siano in qualche modo obbligati e il rispetto delle quali concretizzi una sorta di sfera valoriale cui l’intera comunità possa far affidamento e riferimento. E va bene. Ma questo è il Diritto, non il Valore. Il diritto, è ovvio, è un valore in sé, ma si tratta di una costruzione nostra, in natura non c’è il diritto e ognuno si prende quando e come può tutto quello che può. Ossia, esso non è un valore fondativo, assoluto, che emerge da necessità intrinseche dell’essere. È valore per la società, non valore in sé. Detto altrimenti: il diritto non scaturisce da una necessità ontologica dell’essere, bensì da una necessità morale. Di conseguenza deriva dal Logos, non è esso stesso Logos.
L’in sé del valore viene genericamente identificato con una sostanza metafisica che si dispiegherebbe parallelamente all’esserci umano, al Dasein, come lo chiamano i Tedeschi. Ma questa accezione del valore non è condivisibile, né del resto gode di una sufficiente determinazione ermeneutica. Il valore della inferenza di tale sostanza sull’esserci è troppo poco semantico, per dire così, dispone di un linguaggio troppo ristretto e unilaterale per “stringere” davvero sull’essenza del valore di ciò che io sono, qui e ora. Il valore deve essere laico per essere attivo, altrimenti se ne può derogare fin troppo agevolmente, basta guardare per esempio alle avventure vaticane dei figli, e persino figlie, del pontefice, papi a loro turno.
Il valore è ciò che frena dall’infrangerlo, e non per obbligo di legge. Solo perciò è anche ciò che irrora di senso la nostra vicenda terrena. Il senso della nostra vita è quindi transustanziale con un principio primo da cui gli altri non possono che derivare, e questo principio è il valore che esso implicita nella vita stessa. Quindi la domanda è: cosa non deroga mai da se stesso? Cosa ha la forza intrinseca, cogente di travalicare persino il mio interesse in virtù di qualcosa di maggiore del mio interesse? Cosa è maggiore dell’interesse, del profitto particolare, egoistico e comunque concreto del mio tornaconto? Esiste una cosa così?
La mia risposta è: questa cosa esiste ed è la grandezza, ossia la mia grandezza, il mio sentire grande. Non nel senso di una mia qualità particolare, ma in quello di una possibilità di quel sentire che è comunque essente in noi al grado più alto e ultimo di tale essere. Un requisito di cui la natura ha voluto in ogni caso dotare ognuno di noi e che soltanto il nostro capriccio dispone al meglio o al peggio. Quindi, chi declina la propria grandezza in misura del tornaconto che tale palinodia gli promette, frena sul senso della propria vita a beneficio dell’agiatezza che questa frenata gli restituisce. Senza considerare che, se il senso della vita è frenato, quell’agiatezza non serve a nulla, perché non serve al suo cardine più radicale, appunto il senso.
(Si potrebbe qui innestare un discorso sull’autostima: questa è un valore e per non infrangerlo, ossia per il rispetto di me stesso, evito l’atto corruttivo causa dell’infrazione. Questo non basta e non funziona. Se “ogni uomo ha un prezzo”, come vien detto, tale è proprio il prezzo dell’autostima, cui placidamente si rinuncia in cambio di un bel gruzzolo.)
È questa la risposta alla domanda etica (la Teodicea): se il valore di ciò che è, cioè il mio valore, è sussunto a qualcosa che è in me, e non altro, estraneo da me, il senso della mia vita è interconnesso alla mia facoltà di far valere come grandezza, ossia in modo assoluto, questa mia scoperta del valore. Se rimpicciolisco questo mio obiettivo piegandolo a interessi particolari e circoscritti, infango il mio orizzonte più vasto a favore di un microcosmo più gretto e mediocre, generando discredito su di me e collera in altrui. (esempio: il politico corrotto). E perché non farlo, se se ne trae un vantaggio venale? La questione cade proprio qui: solo il valore come grandezza morale si oppone a questa domanda. Se, diciamo, un sia pur piccolo bottino sembra più grande della mia presunta grandezza, allora è il senso della mia vita che è discreditato: è perché io non so pensarla una tale grandezza che mi accontento di una piccola parcella in contro-moneta del mio credere in me. È l’essere-meschino il controvalore del valore dell’essere. È l’immeschinimento della grandezza necessaria dello spirito a rendere vano e anacronistico il principio stesso del valore.
»
- Blog di Hjeronimus
- Login o registrati per inviare commenti
- 1660 letture

 Sostieni anche tu il nostro sito
Sostieni anche tu il nostro sito
 le nostre pubblicazioni
le nostre pubblicazioni