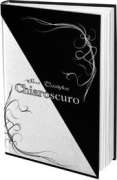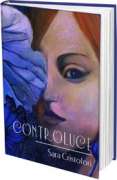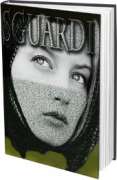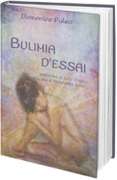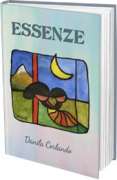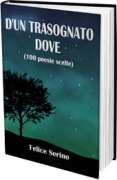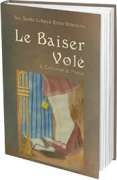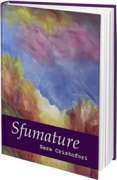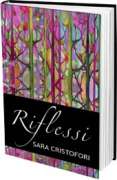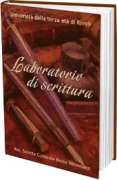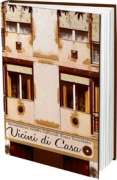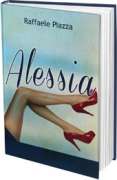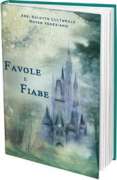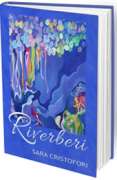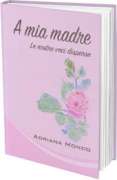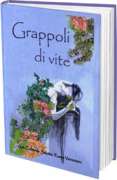Quanti tentano di collegare politica e moralità, si trovano spesso di fronte ad una grande delusione; dal momento che assai sovente ogni tentativo di obiettivo morale da parte dei partiti politici sfocia in una serie di argomentazioni alquanto vuote e strumentalizzanti. In una cultura pluralistica come la nostra, questo genere di tentativo da parte dei vari gruppi politici, conduce immancabilmente a svariate forme di tirannia e molto più spesso finiscono con il creare molti più problemi di quanti ne vorrebbe risolvere.
La scissione tra moralità e politica è diventata sempre più profonda nel corso dei tempi: nell’antichità il re stabiliva le regole secondo il proprio carisma, la propria abilità e compassione assieme ad altre qualità che facevano di lui un re buono e giusto, degno di nota nella storia dell’umanità. Basti ricordare le mitiche figure di re Salomone o Artù, anche se oggi ci sarebbe da discutere se queste figure potrebbero essere considerate politiche in senso moderno e reale.
Ogni re a suo modo, è stato dispotico ed immorale, ma se compariamo queste figure a quello che è lo scenario politico dei nostri giorni, potremo facilmente constatare che la moralità rivestiva un ruolo decisamente importante nella “Politica“ dell’antichità, a differenza dei tempi a venire dove si sarebbe trasformata in qualcosa a se stante: la moralità individuale del monarca diventerà la moralità del gruppo o di una specifica religione, gli obiettivi almeno formalmente saranno sempre di natura morale, ma il modo di centrarli sarà poi di natura esclusivamente politica.
Con la nascita della politica moderna il ruolo della morale all’interno della Politica subirà dei notevoli cambiamenti: Niccolò Macchiavelli, nel suo Il Principe anticipa incredibilmente i tempi quando descrive un monarca benevolente seppur dispotico, le cui strategie politiche possono essere considerate blasfeme ma stranamente obbligatorie secondo gli standards attuali.
Il principe tratta la moralità non come qualcosa che limita le sue azioni, e neanche come il fondamento della sua autorità e della sua legittimità, dal momento che le persone giudicano le azioni del Principe utilizzando categorie morali e la moralità diviene il mezzo per ottenere l’approvazione del popolo.
Il Principe semplicemente, separa la sua personale morale dai bisogni e dalle necessità politiche che sono: La ragione di Stato. Machiavelli non visse abbastanza per vedere nascere la democrazia e il capitalismo, se fosse stato altrimenti, avrebbe visto l’applicazione delle sue teorie in pieno, dal momento che la moralità è trasformata in una sorta di specchio per le allodole; un mero strumento ad uso e consumo delle più svariate strategie politiche.
Le qualità morali di un principe nell’antichità sono date per scontate nei moderni leaders, invece esiste un patto implicito di fiducia fino a prova contraria e le ragioni economiche hanno la meglio su tutte le altre questioni. Sebbene la gran parte degli obiettivi politici si avvalgono di argomenti morali, come l’aborto, l’assistenza, la ricerca biologica, la riduzione tasse, l’immigrazione: l’aspetto morale al centro di queste questioni, si discosta notevolmente dal passato, e venendo a mancare di aspetti personali ha quasi esclusivamente valenze sociali. Alla morale assoluta del passato si sostituisce una morale relativa come conseguenza della pluralità dei vari gruppi sociali e dei loro interessi: gli obiettivi rimangono morali ma le azioni per ottenere la forza e il potere per risolvere questi obiettivi si basano paradossalmente spessissimo su caratteristiche tutt’altro che morali.
Tuttavia sono proprio la moralità e le emozioni più profonde ad essere manipolate dai soliti cacciatori di voti, un sano scetticismo aiuterebbe le persone ad essere più caute, a chiedere maggiori garanzie, ma molto più spesso il bisogno di una ubriacatura ha la meglio su un maturo criticismo che consenta di individuare i giochi di potere oltre alle accattivanti e rassicuranti messainscena. Fino a che continueremo a votare sulla scia della nostra emotività saremo facilmente manipolati, ingannati e immancabilmente delusi.
- Blog di Antonella Iurilli Duhamel
- 1030 letture

 Sostieni anche tu il nostro sito
Sostieni anche tu il nostro sito

 le nostre pubblicazioni
le nostre pubblicazioni